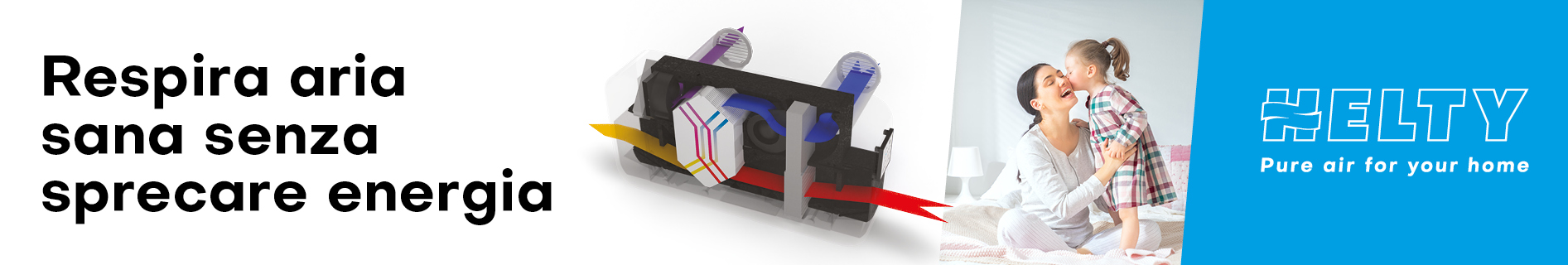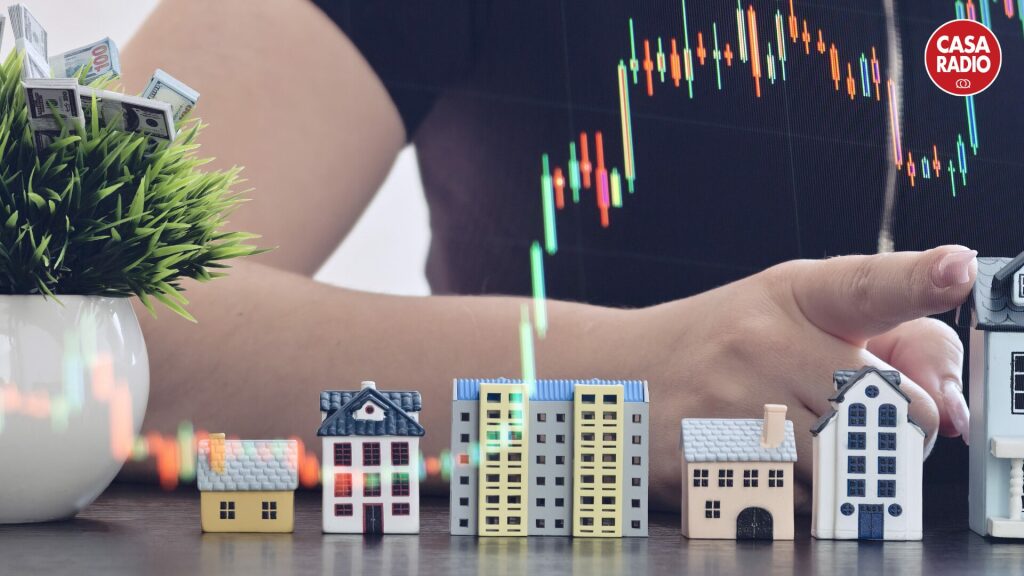Milano ama definirsi la “capitale morale d’Italia”. Una città da sempre proiettata verso il futuro, l’unica vera capitale europea d’Italia, si dice, laboratorio della transizione ecologica e della rigenerazione urbana. Aderisce con orgoglio al C40, la rete internazionale delle metropoli impegnate a raggiungere zero emissioni nette entro il 2050, a promuovere trasporti sostenibili, edifici efficienti, spazi verdi.
Ma mentre sulla carta si piantano alberi e si annunciano ambiziose strategie climatiche, la realtà sembra raccontare con insistenza un’altra storia.
Negli ultimi giorni, la città è finita sotto i riflettori per una vicenda giudiziaria complessa che coinvolge figure di rilievo del mondo imprenditoriale e istituzionale. Non entriamo nel merito dei capi di imputazione, che spetterà alla magistratura valutare. Ci limitiamo a sottolineare come tutto questo sia avvenuto all’ombra di uno degli assessorati più strategici e ambiti: quello all’urbanistica, ovvero un pezzo importante a livello di indirizzo politico e amministrativo della transizione ecologica milanese, ma anche tra i più ambiti per la relazione stretta con l’economia del territorio.
Questo fatto, di per sé, è già un segnale forte.
Ci obbliga a riflettere sul vero significato della sostenibilità. Non è – e non può essere – solo un insieme di parametri ambientali o un’operazione di restyling urbano. Non basta costruire palazzi “green”, piantare alberi sui tetti o parlare di resilienza climatica nei convegni.
La sostenibilità è, prima di tutto, una questione etica. È legalità, equità, trasparenza, giustizia sociale. È rispetto per le persone, per i territori, per le regole. È la capacità di progettare non solo città più verdi, ma comunità più giuste.
Sostenibilità significa prendersi cura del bene comune e creare le condizioni per una prosperità diffusa, dove i benefici dell’amministrazione della cosa pubblica non siano appannaggio di pochi ma patrimonio condiviso.
E ciò che inizia ad apparire sempre più evidente è che questo “sistema” milanese – proprio perché costruito nella capitale economica del Paese – non poteva esistere senza la presunzione che, qualora scoperto, fosse ricondotto nei termini della legalità dalla politica romana, attraverso il tanto invocato “Salva Milano”. Come a dire: tiriamo la corda, e nel momento in cui si spezza, qualcuno la riaggiusterà, normalizzando l’anomalia, rendendo lecito l’illecito, disinnescando le responsabilità con la diplomazia del potere.
Ma questa è sostenibilità?
No. È la sua parodia.
Se non si accetta il principio che la sostenibilità è coerenza morale prima che strategia ambientale, essa resterà solo una bandiera da sventolare quando fa comodo. Un’etichetta per vestire il vecchio con il nuovo, mentre la fiducia si sgretola e i cittadini restano spettatori di un copione già visto.
Ciò che dovrebbe essere piantato – oltre agli alberi contro le isole di calore – sono semi di legalità, responsabilità e fiducia. Perché solo in una città dove le regole valgono per tutti, dove l’interesse collettivo guida le scelte, dove le trasformazioni non sono guidate dai più forti ma condivise da tutti, può davvero nascere una sostenibilità autentica. E con essa, un futuro degno di essere abitato.